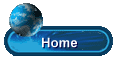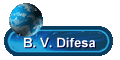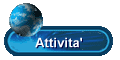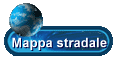Pieve di S. Martino Vigo di Cadore

![]()
San Martino: chiesa plebana

La presenza
di una piccola chiesa sul "Col de San Martin" è riferibile
al tempo dei Franchi (post 774). Certamente esisteva
nel 1186 una cappella con sacerdote (presbiter Enrico)[1]dedicata a S. Martino,
che nel documento del 1208 rogato a Vicenza è nominata ecclesia[2].
La chiesa parrocchiale attuale è stata costruita attorno al 1559 da maestranze
riconducibili al mastro carnico Nicolò Ruopel con l’aggiunta delle navate
laterali nel primo ‘700. In relazione all’ingrandimento della chiesa si
ricostruisce il campanile con un ampio uso di tufo, materiale pregiato per
l’epoca e databile 1599, come dimostra l’iscrizione posta sull’architrave della
porta[3].
All’interno la chiesa conserva delle opere di straordinaria importanza: tra le
opere più antiche e artisticamente più affascinanti è da segnalare il trittico
raffigurante San Martino tra i santi
Candido e Maurizio, recentemente restaurato. La tempera raffigurante San Martino tra i santi Candido e Maurizio, attribuita dal
Cavalcaselle (1912) ad Antonio Rosso è datata 1492.
Di
diversa opinione è Gabriella Dalla Vestra (1975), che non riconosce nell’opera
particolari caratteristici di Antonio Rosso, ed attribuisce la tavola piuttosto
ad “ un artefice altoatesino della fine del ‘400 affine al pittore che dipinse
nei primi del ‘500 la parte esterna del cassettone esistente nella sacrestia
dell’Arcipretale di Pieve”[4].
Nella controfacciata della chiesa trovano posto due
tele raffiguranti i compatroni della parrocchia ed attribuite a Cesare
Vecellio, La decollazione del Battista
e Santa Caterina d’Alessandria.
L’artista nacque a Pieve di Cadore nel 1521 ed era legato con parentela di
secondo grado al più famoso Tiziano. Valcanover ipotizza un apprendistato del
pittore presso la bottega cadorina di Francesco Vecellio e un successivo
trasferimento a Venezia presso Tiziano prima del 1548 “per imparare qualcosa
della professione del pittore”[5].
Cesare vive sempre all’ombra del cugino che non permetteva l’emergere di nuovi
collaboratori poiché “ troppo egocentrica, prepotente era la figura di Tiziano
per lasciar posto a quella di altri”[6].
Cesare inizia a dipingere in
forma autonoma solamente dopo la morte del maestro, nel 1576, e si dimostra
memore non tanto di Tiziano, ma del Tintoretto[7];
è ricordato dagli storici dell’arte come il discepolo migliore di Tiziano
grazie alla sensibilità con cui tratta la prospettiva e al minuzioso studio
sull’architettura.
I rapporti con la comunità di
Vigo sono noti attraverso il Libro dei
conti della “Regola di Vigo” relativamente al quinquennio 1581-1585: in una
nota del 19 marzo 1585 sono ricordate la “pala
de San Daniel (ora nella chiesa di San Daniele) et quella de Santa Margarita”[8]
(presente nella chiesa di Santa Margherita fino al restauro della chiesa stessa
avvenuto nel 1973, poi rimossa perché non consentiva la visione dell’affresco
della parete est). Le tele presenti nella chiesa parrocchiale di San Martino
sono databili attorno al 1583, come risulta dall’incarico che i rappresentanti
del Lume affidarono al pittore in data 18 marzo[9].
La Santa Caterina è stata compromessa da puliture esasperate e da
numerosi ritocchi[10]che
implicano una modifica importante a livello stilistico. La Decollazione del Battista è stata danneggiata da una bruciatura
piuttosto estesa nella parte superiore sinistra dell’opera, il che ha reso
necessari ampi rifacimenti[11]
implicando anche in questo caso una modifica importante all’impianto stilistico
originale dell’opera.
Nella parrocchiale inoltre è da
mettere in risalto una delle opere più pregevoli conservate a Vigo di Cadore: la crocifissione lignea di Valentino
Panciera Besarel (1829-1902). Ultimo intagliatore della famosa bottega zoldana
dei Besarel, Valentino ebbe la fortuna di poter studiare prima a Belluno e in
un secondo momento a Venezia.
La pala di Vigo si può
considerare una libera interpretazione, ad altorilievo, della pala di Andrea
Brustolon che si trova nella chiesa di S. Pietro a Belluno. Questa pregevole
pala fu esposta ed ammirata prima all’esposizione Universale Permanente,
inaugurata a Venezia per la venuta di Vittorio Emanuele II (ottobre 1866), e
l’anno seguente all’Esposizione Universale di Parigi[12].
La presenza a Vigo di un’opera
così importante ed ammirata non fa che aggiungere, ad uno scenario artistico
già ricco, un’altra importante bellezza. A documentare uno sforzo economico
notevole da parte della popolazione è testimone una lettera, firmata don
Simeone Del Favero e datata 19 nov. 1864, dove si parla della seconda rata
pagata a Valentino Besarel per l’opera di Lire 618.63.
A questo punto proponiamo al lettore una
visita virtuale alle opere d’arte conservate
nella chiesa di San Martino[13].
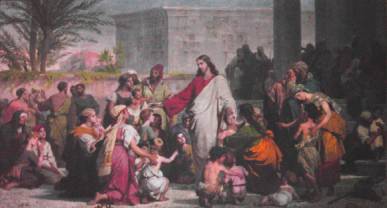

Iniziamo dal presbiterio: l’altare maggiore,
costruito in marmo, è del 1813 opera di Pietro Andreis da Barcis (PN) con
bottega a Longarone. Di notevole interesse,
per accuratezza formale, le statue marmoree laterali che rappresentano S.Giovanni
Battista e S.Caterina d’Alessandria, compatroni della parrocchia. San Martino è
riprodotto in scultura equestre nell’atto di donare il mantello ed è accostato
alla parete absidale poco sotto la lunetta centrale. Le vetrate raffigurano
S.Bernardino da Siena e S.Antonio Abate, patroni rispettivamente di Pelos e
Laggio. Il coro in radica è del 1739. Sempre nel presbiterio due bellissime
tele di grandi dimensioni, opere di Tomaso Da Rin Betta (1838-1922) artista nato a Laggio e raffiguranti
“Gesù in mezzo ai fanciulli” (1885) e la “Cacciata dei profanatori dal Tempio”
(1881); la sede del celebrante, in legno pregevolmente intagliato. L’altare
ligneo per le celebrazioni eucaristiche (2002) è di Conrad Moroder, scultore
gardenese di Ortisei (BZ), mentre l’ambone ligneo (2004) riprende lo stile
secentesco della cattedra posta a metà navata.
L’altare laterale di destra “del Crocefisso” è caratterizzato dalla pala lignea raffigurante “la Maddalena ai piedi della croce”. E’ opera magistrale di Valentino Panciera Besare detto il Besarel da Forno di Zoldo (BL). Collocata nel 1866 è considerata il capolavoro d’arte sacra del valente scultore bellunese.

L’altare laterale di sinistra “della Madonna”
conserva la statua lignea della “Beata Vergine del Rosario”, opera di Carlo e
Raffaele Piazza da Lorenzago, discepoli del Besarel. E’ del 1899.
Sopra la porta della sagrestia (in prossimità dell’altare del
crocefisso) è collocata l’opera scultorea di Tommaso De Nicolò da Vigo del
1861, raffigurante i pievani Da Rù benemeriti per la loro attività caritativa.
Alla sua destra il trittico, tempera su
tavola (1492) con le figure dei Santi Martino, Candido e Maurizio, attribuito
ad Antonio Rosso da Tai. Nei pressi il busto bronzeo del Cardinal Giovanni Adeodato Piazza
(1884-1957), nativo di Vigo, patriarca di Venezia e
Segretario della Congregazione per i Vescovi.
A circa metà navata principale l’antica cattedra “della dottrina”.
Da notare pure l’artistico lampadario di bronzo dorato in stile veneziano. E,
alle pareti la Via
Crucis, riproduzione in stampa su tela del ciclo
pittorico di Giovanni Domenico Tiepolo i cui originali (1749) sono custoditi in
S. Polo (S. Paolo) a Venezia.
In prossimità dell’ingresso principale si trovano due altari
minori: quello di destra dedicato a S.Giuseppe. La pala raffigura l’agonia del
Santo ed è siglata Arsie P (1744) (Felice Arsiè da Longarone?). L’altare di sinistra è dedicato ai SS. Rocco
e Sebastiano. La pala raffigura i Santi con la Sacra Famiglia. E’ di Tomaso Da
Rin Betta (1894), pagata 1200 lire. In prossimità vi si trova l’interessante fonte battesimale in
pietra scalpellata (1609), mentre il coperchio in ottone sbalzato è d’artigianato trentino (1995).
Sulla parete di fondo (parete del portone d’ingresso) si possono
ammirare due opere del ‘500: la decollazione di S.Giovanni Battista (1583) e
S.Caterina d’Alessandria (1589) di Cesare Vecellio, parente del noto Tiziano.
Così pure sono di particolare interesse i confessionali restaurati
e l’acquasantiera in marmo rosso di Erto, risalente al XVI secolo. L’organo Barbini (1757) rinnovato
da Aletti (1894), di pregevole effetto
fonico <(ascolto), annoverato tra gli organi storici del Cadore, trova posto
nella cantoria in stile barocco, la cui balconata mostra decorazioni di ottima
fattura. E’ uno strumento costruito “alla maniera antica” con 30
registri, tastiera di 58 note, pedaliera a leggìo di 21 pedali. Le canne del
Barbini sono le più antiche residenti in Cadore.
Il “Cristo Risorto”, olio su tela, XV stazione della Via Crucis, è
opera del pittore cadorino Nazareno Corsini (2000).
Di particolare interesse risultano le statue lignee colorate: il
“Sacro Cuore” (2002) è d’artigianato gardenese della bottega di Albert Comploj, mentre il “San Martino vescovo” è
opera dello scultore Helmut Perathoner di Ortisei (2003).
Ogni epoca storica ha lasciato
nella pievanale il proprio “segno” inconfondibile nel rispetto di un
equilibrio generale percepibile dal visitatore.

Sulpicio Severo: vita di S. Martino
Venanzio Fortunato: vita di S. Martino
Atto di consacrazione della chiesa
Il San Martino di Domenico da Tolmezzo
Cardinal Piazza: Una spiritualità in servizio pastorale
Webcam Vigo Vigo: vista dal campanile
[1] F. Pellegrini, De Dona’ G., Appunti storici sui pievani di Vigo di Cadore
[2] E’ da considerare parrocchia ma non nel senso pieno del diritto canonico attuale. Infatti il presbitero rettore risiedeva nella comunità ben definita ed esercitava di fatto la cura d’anime, eccetto il battesimo, usufruendo di un beneficio.
[3] G. Fabbiani, Chiese del Cadore, Belluno 1963, p.195.
[4] G. Dalla Vestra, I pittori bellunesi prima del Vecellio, 1975, p. 57.
[5] F. Valcanover, Mostra dei Vecellio, Belluno 1951, pp. 38-51.
[6] T.Conte, Cesare Vecellio 1521-1601, Belluno 2001, p.13.
[7] F. Valcanover, Mostra dei Vecellio, Belluno 1951, pp. 38-51.
[8] T.Conte, Cesare Vecellio 1521-1601, Belluno 2001, p. 165.
[9] Appunti storici sui pievani di Vigo di
Cadore, F. Pellegrini, G. De Donà
[10] M.Mazza, “Emergenze artistiche nelle chiese di Vigo di Cadore…”, in Vigo di Cadore, a cura di Rita Bernini, Belluno 2003, p.43.
[11] Ibidem
[12] G. Angelini e E. Cason Angelini, Gli scultori Besarel Panciera di Zoldo, Belluno 2002, pp.82-84.
[13] Vigo e il suo Cardinale, Giovanni Maria Longiarù
![]()
Copyright(c) 2001 Nome società. Tutti i diritti riservati.
myid@myhost.com