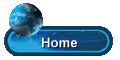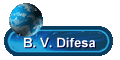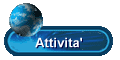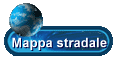Pieve di S. Martino Vigo di Cadore
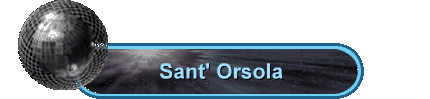
![]()
La chiesa e il culto di Sant’Orsola
la chiesa è un piccolo santuario perché conserva un frammento osseo della Santa, proveniente dal reliquiario di Colonia

La chiesa,
cappella funeraria dedicata a Sant’Orsola,
è sorta nell’odierna piazza di Vigo; al suo interno presenta il ciclo pittorico
più interessante e prezioso di tutta la valle cadorina. Il Ronzon (1874) la
dice “costruita nel 1344 dalla pietà di Ainardo da Vigo, forse la più antica
chiesa della diocesi con data di costruzione certa”[1].
Ainardo, figlio di Odorico podestà del Cadore per conto dei Caminesi,
era un rappresentante della classe dirigente cadorina legata ai Da Camino, i
quali risiedevano a Serravalle. Ed è proprio a Serravalle che Ainardo, ormai
malato, redige il suo testamento il 20 maggio 1346, disponendo di essere
sepolto nel locale cimitero di Sant’Andrea di Bigonzo, in attesa di essere
traslato nella chiesa di Sant’Orsola[2],
lasciando inoltre dei beni immobili nella marca trevigiana a disposizione dei
rettori di Sant’Orsola. Il prestigio di Ainardo è visibile in molte vicende
cadorine del XIV secolo; è importante metterlo in risalto durante la
dominazione tedesca (1337-1347), quando il Cadore divenne il crocevia di
transiti commerciali e si sviluppò una particolare rete di scambi con la bassa
Austria; questo spiegherebbe inoltre il matrimonio di Ainardo con Margherita di
Leisach (nei pressi di Lienz). Partecipò pure alla stesura degli Statuti Cadorini
del 1338.
Carlo Rapozzi, alla metà del '900, pubblicò alcuni studi sulla chiesa che sono consultabili presso la Biblioteca Storica Cadorina di Vigo di Cadore o presso l'Archivio Storico di Belluno Feltre Cadore. Tra l'altro scrive che l'autore degli affreschi della chiesa di S. Orsola, eseguiti tra il 1346 e il 1350, è forse Bernardo da Serravalle.L'affresco di Vigo di Cadore presenta analogie con quello di S. Orsola nella cappella vecchia del Castello di S. Salvatore di Susegana (Conegliano), eseguito dallo stesso pittore.
Secondo l’interessante studio di Tiziana Franco fatto sulla chiesa di Sant’Orsola, i dati certi sono tre: La chiesa è già costruita nel 1345.
Fino al luglio del 1348 essa non
è consacrata.
Almeno nelle indicazioni
testamentarie di Ainardo e Giusto (fratello di Margherita ed erede del
patrimonio di Ainardo) essa dovrebbe raccogliere le loro tombe. La dedicazione
a Sant’Orsola dovrebbe essere avvenuta
a cavallo tra il 1349 e il 1350.

In un articolo degli anni ’50, del XX secolo, scritto dal dott. De
Lotto e pubblicato nel “Il Gazzettino”
si parla di un graffito letto dal professor Mor dell’Università di Modena che
rivelerebbe la data, il nome del committente e forse l’autore, di cui però nel
corso degli anni si è persa la memoria.
Il ciclo si mostra ai nostri
occhi diviso in tre registri da delicate cornici ornamentali: il primo registro
ci presenta un motivo decorativo chiamato velum
con delle singolari figure che ne reggono i lembi. “Due di queste figure si
trovano ai lati dell’altare; una terza atteggiata come se spostasse con forza
il drappo verso sinistra per stenderlo”, è a metà circa della parete destra e
tutto fa pensare che avesse un corrispettivo su quella opposta, dove ora si
apre la cappella di San Lazzaro[4],
(nella quale è presente una tela dedicata al santo[5]).
Il secondo invece ci presenta la
descrizione della storia di Sant’Orsola in dieci scomparti affrescati, purtroppo menomati
nella parete di sinistra, dove è stata aperta la postuma cappella laterale.
Nel terzo registro la Vergine
con il bambino campeggia contro l’azzurro della volta celeste. La circondano i
simboli dei quattro evangelisti e, in origine, dovevano risplendere delle
stelle dorate. Sulla parete di fondo campeggia la crocifissione con una
descrizione biblica degli avvenimenti accaduti attorno al calvario.
La parte alta della parete
d’ingresso è occupata da una scena della vita di San Giorgio ambientata in un
paesaggio roccioso. Sotto di essa dovevano esserci tre riquadri. Ne restano
soltanto due che rappresentano San Martino e San Daniele.
Il Rapozzi suggerisce che questi
Santi "sono stati oggetto di particolare devozione a Vigo e nel suo territorio”[6].
A
nostro avviso il ciclo di Sant’Orsola è un ‘espressione eccezionale di arte
gotica; ricordiamo che il professore Bettini (1933) considera la migliore opera
gotica italiana la “ Divina Commedia”
perché segna il passaggio dall’oscurità alla luce in maniera totale ed
incisiva.
Nella
chiesa di Sant’Orsola questo passaggio simbolico e teologico è espresso nei tre
registri: il primo (livello delle pitture del velum ma, soprattutto, delle
persone che entrano in chiesa) è identificabile con l’uomo peccatore che vive
sulla terra; come ci ricorda San Paolo “E non c’è distinzione: tutti hanno
peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente
per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù”. (S.
Paolo, Let. ai Romani 3, 23-24).
Il
secondo registro, appena più alto del livello umano, ci mostra la santità di
Sant’Orsola acquisita tramite la fede, la speranza e l’esercizio della carità.
La
santa vedeva le forze oscure, demoniache, come immagini bestiali (in questo
caso Attila) e percepiva che il suo scopo è sopraffare una dimensione
selvaggia, maligna. E, come contrapposizione a questo mondo sotterraneo di
bestie passionali e feroci si poneva il mondo celeste, spirituale, il mondo di
Dio. La fermezza di andare incontro al martirio per coerenza di fede e per poter liberare Colonia dagli Unni rivela
un grande gesto di lotta spirituale.
Chiunque ama sa quanto sia
raffinato il mondo dell’amore e quanto sottile sia l’inganno, ma il “giusto vivrà mediante la fede”
(San Paolo, Let. ai Romani 1, 17).
Il terzo registro, detto anche
teologico, da risalto alla crocifissione di
Cristo, il momento fondamentale della manifestazione dell’Amore di Dio.
Il figlio di Dio si consegna completamente all’uomo, lasciando che l’uomo compia
verso di Lui la violenza del male. Cristo sulla croce si è fatto servo, un
servo così umile che anche i servi lo possono percuotere ed umiliare fino alla
morte di croce. Il Padre, permettendo la passione e la morte del Figlio,
coronata dalla resurrezione, ha voluto che il mondo si scopra amato da Lui e
arrivi a tal modo alla vera conoscenza. E l’uomo “scopre” che la nefandezza e
l’iniquità fanno parte del suo essere, nascono dal suo comportamento.
La chiesa di S. Orsola è stata visitata da Papa Benedetto XVI nel luglio 2007, che vi si è trattenuto in preghiera.
Nel 2008 l'arcivescovo di Colonia Card. Joachim Meisner fece dono della reliquia di Santa Orsola (frammento osseo) che è conservata in teca reliquiario
[1] A. Ronzon, Dal Pelmo al Peralba, vol. I, 1874.
[2] T. Franco, Gli affreschi della chiesa di Sant’Orsola di Vigo di Cadore, p.11.
[3] G. Dalla Vestra, I pittori bellunesi prima del Vecellio, 1975, pp. 14-19.
[4] T. Franco, Gli affreschi della chiesa di Sant’Orsola di Vigo di Cadore, p.18.
[5] Secondo Carlo Rapozzi il quadro è opera del Tommaso Vecellio (1587-1629) che lo eseguì tra il 1609 e il 1610.
[6] T. Franco, Gli affreschi della chiesa di Sant’Orsola di Vigo di Cadore
![]()
Copyright(c) 2001 Nome società. Tutti i diritti riservati.
myid@myhost.com